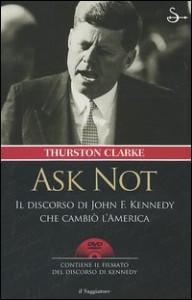Ciao, Chicago!
Se là fuori c’è ancora qualcuno che dubita che l’America sia un luogo dove tutto è possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri Fondatori sia vivo nella nostra epoca, che ancora mette in dubbio la forza della nostra democrazia, questa notte è la vostra risposta.
È la risposta data dalle file di elettori che si estendevano intorno alle scuole e alle chiese, file mai viste prima da questa nazione, è la risposta che hanno dato le persone che hanno aspettato tre, quattro ore, molti per la prima volta in vita loro, perché erano convinti che questa volta doveva essere diverso, che la loro voce poteva fare la differenza.
È la risposta pronunciata da giovani e vecchi, ricchi e poveri, democratici e repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, nativi americani, gay, etero, disabili e non disabili: americani che hanno inviato al mondo il messaggio che noi non siamo mai stati semplicemente un insieme di individui o un insieme di Stati rossi [Repubblicani] e Stati blu [Democratici]: noi siamo e saremo sempre gli Stati Uniti d’America.
È la risposta che ha spinto quelli che per tanto tempo, da tanta gente, si sono sentiti dire che dovevano essere cinici, spaventati, scettici su quello che possiamo fare, sulla possibilità di mettere le mani sul corso della storia e piegarlo in direzione della speranza di un giorno migliore. Ci ha messo molto ad arrivare, ma questa notte, grazie a quello che abbiamo fatto in questa giornata, in queste elezioni, in questo momento storico, il cambiamento è arrivato in America.
Poco fa ho ricevuto una telefonata estremamente gentile da parte del senatore McCain. Il senatore McCain si è battuto a lungo e con convinzione in questa campagna, e ha combattuto ancora più a lungo e con ancora più convinzione per il paese che ama. Ha sopportato sacrifici per l’America che la maggior parte di noi non riesce neppure lontanamente a immaginare. Tutti abbiamo beneficiato dei servizi resi da questo leader valoroso e altruista. Gli faccio le mie congratulazioni, faccio le mie congratulazioni alla governatrice Palin per tutto quello che hanno saputo fare, e spero veramente di poter lavorare insieme a loro nei mesi a venire per rinnovare le promesse di questa nazione.
Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio in questa avventura, un uomo che si è impegnato nella campagna con tutto il suo cuore e ha dato voce agli uomini e alle donne con cui è cresciuto nelle strade di Scranton e con cui ha affrontato il viaggio sul treno verso casa in Delaware, il vicepresidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden.
E non sarei qui stanotte senza l’incrollabile supporto di quella che è stata la mia migliore amica negli ultimi 16 anni, la roccia della nostra famiglia, l’amore della mia vita, la prossima first lady della nazione, Michelle Obama.
Sasha e Malia, vi amo tutte e due, più di quanto possiate immaginare, e vi siete guadagnate il nuovo cucciolo che verrà con noi alla Casa Bianca.
E anche se non è più con noi, so che mia nonna sta guardando, e con lei la mia famiglia, che mi ha reso quello che sono. Sento la loro mancanza stanotte, e so che il debito verso di loro è incommensurabile.
A mia sorella Maya, a mia sorella Auma, a tutti i miei fratelli e sorelle, grazie mille per il sostegno che mi avete dato. Vi sono grato.
E al direttore del mio staff elettorale, David Plouffe, l’eroe ignoto di questa campagna, che ha saputo costruire quella che credo sia stata la migliore campagna elettorale nella storia degli Stati Uniti d’America, al responsabile della strategia, David Axelrod, che è stato accanto a me per ogni passo di questo cammino, al migliore team elettorale mai messo insieme nella storia della politica: voi avete reso possibile tutto questo e io vi sarò per sempre grato per quello che avete sacrificato per riuscirci.
Ma soprattutto non dimenticherò mai a chi appartiene veramente questa vittoria. Appartiene a voi. Appartiene a voi.
Non sono mai stato il candidato più probabile per questo incarico. Quando abbiamo cominciato avevamo pochi soldi e pochi appoggi. La nostra campagna non è stata architettata nei corridoi di Washington: è partita dai cortili di Des Moines, dai salotti di Concord, dalle verande di Charleston. È stata costruita da lavoratori e lavoratrici che hanno attinto ai loro magri risparmi per versare 5, 10, 20 dollari per la causa. È diventata forte grazie ai giovani che hanno rigettato il mito dell’apatia della loro generazione, che hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per fare lavori che promettevano pochi soldi e poche ore di sonno. Ha attinto forza da quelle persone non più così giovani che hanno sfidato il freddo pungente e il caldo soffocante per andare a bussare alla porta di perfetti estranei, e da quei milioni di americani che hanno lavorato come volontari e hanno coordinato, e che hanno dimostrato, più di due secoli dopo, che un governo del popolo, dal popolo e per il popolo è ancora possibile. Questa è la vostra vittoria.
Io so che non avete fatto tutto questo solo per vincere un’elezione, e so che non lo avete fatto per me. Lo avete fatto perché siete consapevoli dell’enormità del compito che abbiamo davanti. Perché anche se stanotte festeggiamo, siamo consapevoli che sfide che ci aspettano saranno le più impegnative della nostra vita: due guerre, un pianeta in pericolo, la peggiore crisi finanziaria da un secolo a questa parte. Anche mentre stiamo qui stanotte, sappiamo che ci sono americani coraggiosi che percorrono i deserti dell’Iraq e le montagne dell’Afghanistan rischiando la loro vita per noi. Ci sono madri e padri che rimangono svegli dopo che i loro figli sono andati a dormire e si domandano come riusciranno a rimborsare il mutuo, a pagare i conti dei medici o a risparmiare abbastanza per poter mandare i figli all’università.
Ci sono nuove energie da radunare, nuovi posti di lavoro da creare, nuove scuole da costruire e minacce da affrontare, alleanze da risanare.
La strada che ci aspetta sarà lunga. La pendenza sarà ripida. Forse non ci arriveremo in un anno e nemmeno nell’arco di un mandato, ma, America, io non sono mai stato tanto fiducioso come questa notte che ci arriveremo. Ve lo prometto: noi, come popolo, ci arriveremo.
Ci saranno ostacoli e false partenze. Molti non concorderanno con tutte le decisioni che prenderò come presidente, e sappiamo che il governo non può risolvere ogni problema. Ma io sarò sempre sincero con voi sulle sfide che dovremo affrontare. Vi starò a sentire, specialmente quando non saremo d’accordo. E soprattutto vi chiederò di prendere parte all’opera di ricostruzione di questa nazione nell’unico modo che l’America abbia mai conosciuto nei suoi 221 anni di storia: una casa sull’altra, un mattone sull’altro, una mano incallita dalla fatica sull’altra.
Quello che è cominciato 21 mesi fa in pieno inverno non può finire in questa notte d’autunno. Questa vittoria da sola non rappresenta il cambiamento che cerchiamo: è soltanto l’occasione per noi di realizzare quel cambiamento.
E questo non accadrà se torneremo a com’erano le cose un tempo. Non accadrà senza di voi, senza un nuovo spirito di servizio, un nuovo spirito di sacrificio. E allora creiamo un nuovo spirito di patriottismo, di responsabilità, dove ognuno di noi decide di buttarsi nella mischia e impegnarsi di più, e di occuparci non solo di noi stessi ma gli uni degli altri.
Ricordiamoci che se questa crisi finanziaria ci ha insegnato qualcosa, questo qualcosa è che Wall Street, la grande finanza, non può prosperare se Main Street, l’uomo della strada, patisce. In questo paese, ci alziamo o cadiamo come un’unica nazione: come un unico popolo.
Resistiamo alla tentazione di ricadere nella vecchia faziosità, meschineria e immaturità che avvelena da così tanto tempo la nostra vita politica. Ricordiamo che fu un uomo di questo Stato il primo a portare il Partito repubblicano alla Casa Bianca, un partito fondato sui valori della fiducia nei propri mezzi, della libertà individuale e dell’unità nazionale. Questi sono valori che tutti condividiamo. E se questa notte il Partito democratico ha riportato una grande vittoria, lo facciamo con una parte di umiltà e con la determinazione a sanare le fratture che hanno ostacolato il nostro progresso.
Come disse Lincoln a una nazione molto più divisa della nostra: «Noi non siamo nemici, ma amici: la passione può aver messo a dura prova i nostri legami, ma non deve spezzarli». E a quegli americani di cui ancora devo conquistarmi il sostegno dico: stanotte non ho conquistato il vostro voto, ma ascolto la vostra voce, ho bisogno del vostro aiuto e sarò anche il vostro presidente.
E a tutti coloro che stanotte ci stanno guardando da altri paesi, da regge e parlamenti fino a coloro che stanno stretti intorno a una radio negli angoli più dimenticati del pianeta, dico: le nostre storie sono individuali, ma il nostro destino è comune e una nuova alba di leadership americana è a portata di mano. A coloro che vorrebbero distruggere il mondo dico: noi vi sconfiggeremo. A coloro che cercano pace e sicurezza dico: noi vi sosterremo. E a tutti coloro che si sono chiesti se il faro dell’America splende ancora come un tempo dico: questa notte vi abbiamo dimostrato una volta di più che la vera forza della nostra nazione non nasce dalla potenza delle nostre armi o dalla protata della nostra ricchezza, ma dalla forza costante dei nostri ideali: democrazia, libertà, opportunità e invincibile speranza.
Questo è il vero talento dell’America, il fatto che l’America può cambiare. La nostra unione può essere perfezionata. E quello che abbiamo già ottenuto ci dà speranza per quello che possiamo e dobbiamo ottenere domani.
In queste elezioni ci sono state molte novità assolute e molte storie che verranno raccontate per generazioni e generazioni. Ma una storia che ho in mente stanotte è quella di una donna che è andata a votare ad Atlanta. Assomiglia in tutto e per tutto ai milioni di altri individui che si sono messi in fila per far sentire la loro voce in queste elezioni, tranne che per un aspetto: Ann Nixon Cooper ha 106 anni.
Ann Nixon Cooper è nata appena una generazione dopo la fine della schiavitù: un’epoca in cui non c’erano macchine per le strade o aerei nei cieli; un’epoca in cui una come lei non poteva votare per due ragioni, perché era una donna e per il colore della sua pelle. E questa notte penso a tutto quello che ha visto nel corso del secolo che ha vissuto in America: l’angoscia e la speranza, la lotta e il progresso, i tempi in cui ci dicevano che non potevamo farcela e le persone che hanno tirato avanti fondandosi su quella professione di fede americana: «Sì, possiamo farcela».
In un’epoca in cui la voce delle donne veniva messa a tacere e le loro speranze venivano ignorate, Ann Nixon Cooper è vissuta per vedere le donne battersi per i propri diritti, far sentire la propria voce e ottenere il voto. Sì, possiamo farcela.
Quando c’era disperazione nella regione delle Grandi Pianure e tutto il paese era attraversato dalla depressione, abbiamo visto una nazione sconfiggere la paura stessa con un New Deal, un nuovo patto, con nuovi posti di lavoro e un nuovo sentimento di uno scopo comune. Sì, possiamo farcela.
Quando le bombe sono cadute nella nostra baia e la tirannia ha minacciato il mondo, Ann Nixon Cooper era lì a testimoniare come una generazione riuscì ad assurgere alla grandezza e a salvare la democrazia. Sì, possiamo farcela.
Ann Nixon Cooper era lì per gli autobus a Montgomery, per gli idranti a Birgmingham, per il ponte di Selma e per un predicatore di Atlanta che diceva alla gente “We shall overcome”, noi vinceremo. Sì, possiamo farcela.
Un uomo è atterrato sulla Luna, un muro è crollato a Berlino, un mondo è stato collegato dalla nostra scienza e dalla nostra immaginazione. E quest’anno, in queste elezioni, Ann Nixon Cooper ha messo un dito su uno schermo e ha votato, perché dopo 106 anni in America, attraverso i momenti migliori e le ore più cupe, lei sa che l’America può cambiare.
Sì, possiamo farcela.
Americani, abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo visto tante cose. Ma c’è ancora moltissimo da fare. Perciò questa notte domandiamoci: se i nostri figli dovessero vivere tanto da vedere il prossimo secolo, se le mie figlie dovessero essere tanto fortunate da vivere tanto a lungo quanto Ann Nixon Cooper, quale cambiamento vedranno? Quali progressi avremo realizzato?
Questa è la nostra occasione per rispondere a questo appello. Questo è il nostro momento. Questa è la nostra epoca: per rimettere la nostra gente al lavoro e aprire porte di opportunità per i nostri bambini; per riportare la prosperità e promuovere la causa della pace; per rivendicare il sogno americano e riaffermare quella verità fondamentale, che da molti siamo uno; che finché avremo vita avremo speranza: e quando ci troveremo di fronte al cinismo e al dubbio, e a quelli che ci dicono che non ce la possiamo fare, noi risponderemo con quella professione di fede immortale che riassume lo spirito di un popolo: sì, possiamo farcela.
Grazie. Dio vi benedica. E che Dio benedica gli Stati Uniti d’America.
(Traduzione di Fabio Galimberti – Il sole 24 ore)