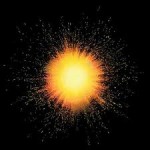Un po’ a tutti è venuto il dubbio che per sortire dalle secche in cui è precipitata la sinistra, non solo italiana, congressi e beghe di partito non siano sufficienti figurarsi salvifici. Le dimensioni del tracollo, del distacco, denotano un cambio di fase che necessiterebbe di riflessioni ampie, di progetti politici che rimettessero in discussione gli ultimi 20 o 25 anni della sinistra, quanto meno di quella riformista che è statala spina dorsale del socialismo europeo dalla caduta del muro di Berlino.
Anche qui serve una prima distinzione: le tendenze più liberali o mercatiste di questa sinistra hanno trovato, o più correttamente stanno tendando, di trovare strade autonome: Macron in Francia, i liberali britannici, Calenda (forse) qui da noi; proseguono la strada di un governo della mondializzazione, banalizzando, continuando la terza via del riformismo degli anni ’90 del XX secolo che però pare essere proprio quello che l’elettorato europeo rifiuta come l’aglio i vampiri. La sinistra più radicale sembra invece rivolgersi al passato, riscoprendo un calore e una voglia di lottare che fanno piacere e potranno certamente tornare utili, ma appaiono guardare ancora più indietro nel tempo riproponendo ricette eticamente corrette ma in un contesto sociale e economico che non è in grado di accoglierle senza un mutamento complessivo, rivoluzionario si sarebbe detto un tempo.
Tra queste due tensioni ideali sembrerebbe necessario, almeno a chi scrive, trovare una strada diversa che non acconsentisse ai dogmi dell’economia mondiale di mercato ma che nemmeno implicasse come soluzione il ritorno a un eden socialdemocratico che non potrà tornare. In questo filone si colloca il manifesto di AG.I.R.E. , un gruppo di studiosi di cui fanno parte Maurizio Franzini, Elena Granaglia, Ruggero Palladini, Andrea Pezzoli, Michele Reitano e Vincenzo Visco e che si sono posti come obiettivo dell’agire politico di un nuovo riformismo un nemico tosto come la disuguaglianza.
Proprio come Keynes e i liberali britannici durante laseconda guerra mondiale immaginarono un mondo in cui l’economia di mercato dovesse essere temperata da azioni pubbliche che la regolassero e facessero godere i dividendi a quanti più cittadini possibile (certo anche per sopravvivere alla spinta del comunismo avanzante), il gruppo AG.I.R.E. immagina un mondo in cui redistribuire la ricchezza della rivoluzione informatica, ridefinire il ruolo di un governo pubblico (magari sovranazionale) non più mero regolatore e poter colmare il divario tra i primi sempre più primi e le masse sempre più ampie di ultimi.
Il volume è uno spunto interessante, seppur nella parte delle azioni politiche concrete sia piuttosto vago e poco incisivo, e cerca di ridefinire alcuni parametri che parevano intoccabili (la globalizzazione buona e giusta, il mercato in grado di trovare da sé i correttivi, il pubblico come inevitabile fonte di sprechi e inefficienze) e di contrapporre argomenti al pensiero dominante degli ultimi 25 anni, in base al quale l’aumentare della disuguaglianza all’interno dei paesi “ricchi” sarebbe compensato dall’avvicinarsi dei paesi “poveri” a quelli ricchi con il conseguente aumento delle condizioni di vita dei più poveri di quei Paesi.
Altro aspetto interessante del volume è il mix di misure immaginate per combattere la disuguaglianza, intravedendo azioni macroeconomiche, cessioni di sovranità a organismi sovranazionali ma anche azioni di nudge economics applicabili a livello locale.
Insomma pur non ponendosi come un manifesto per la sola sinistra, il testo edito dal Laterza, appare in questi tempi bui come un piccolo faro di speranza, a patto si riescano a superare gli appassionanti dibattiti sugli inviti a cena, le ex stazioni ricolme di ego, il personalismo spinto e le scissioni di microrganismi politici che paiono essere, ad oggi, un delle poche ragioni di interesse dei gruppi dirigenti della sinistra italiana.
Articolo apparso sul numero 283 del 3 novembre 2018 di www.culturacommestibile.com