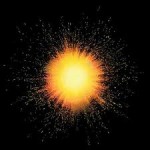I rivoluzionari del XX secolo venivano spronati dalla propaganda dei partiti afferenti alla III internazionale ad essere due volte migliori dei capitalisti che si proponevano di abbattere. La tesi era che l’avanguardia rivoluzionaria avrebbe, col proprio esempio, fatto prendere coscienza al proletariato fino al suo riscatto.
Qui in Italia i gruppi che diedero vita a Livorno al PCdI si affermarono intorno a due riviste, il Soviet di Bordiga e l’Ordine Nuovo dei “torinesi” Gramsci, Togliatti, Tasca, Terracini e altri. Due riviste di cultura, in cui, soprattutto sull’Ordine Nuovo, i temi dell’organizzazione del nuovo stato sovietico e socialista erano trattati e approfonditi ben oltre lo slogan “faremo come in Russia”. Anzi è proprio in quegli anni che nasce la necessità di uno specifico italiano nella costruzione del socialismo, che poi Gramsci approfondirà nei Quaderni e Togliatti svilupperà, certo anche tatticamente, nella via italiana al socialismo del secondo dopoguerra.
Studiare, confrontarsi, migliorarsi era la regola. D’altra parte Angelo Tasca, per convincere un giovane e timido Antonio Gramsci ad unirsi alle loro riunioni gli fece dono di un volume di Guerra e Pace con la seguente dedica “Al compagno di studi, oggi, al mio compagno di battaglia, spero, domani”; mentre il motto che campeggiava in prima pagina de L’Ordine Nuovo era “istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.
Un imprinting che ha segnato fortemente non solo il PCI ma più in generale tutto il movimento operaio e progressista italiano. Basti pensare ai sindaci del dopoguerra, quella generazione fatta anche di operai come Fabiani a Firenze, quella in cui “la maestà del popolo governava” come scrisse Neruda nei versi dedicati proprio al primo cittadino di Firenze, che si misurarono con uno Stato in cui le persistenze e le continuità con il regime liberale ma soprattutto fascista erano fortissime e invasive oltre ogni immaginazione. Eppure passo dopo passo modificarono le cose e governarono, come dopo di loro la generazione di amministratori della seconda metà degli anni settanta, che ancor di più scardinarono a livello amministrativo un Paese già profondamente cambiato culturalmente e socialmente. Lo cambiarono in presenza e in reazione ad un attacco allo Stato che proveniva sia dai teorici della rivoluzione che da quelli della reazione, facendo prevalere un senso delle istituzioni di cui gioverà il paese nei momenti bui e confusi dei primi novanta culminati però con la deviazione, purtroppo ampia e tragica, della degenerazione giustizialista e l’avvio della stagione del populismo in politica.
Vi è dunque un portato storico, una prassi, comune alla sinistra ma anche ben presente nella tradizione democratica cristiana (la maggior parte dei dirigenti storici della DC proveniva da cattedre universitarie) di coincidenza di cultura e impegno politico, di consapevolezza che il cambiamento per esser tale avrebbe dovuto sempre confrontarsi con resistenze anche tecnico amministrative.
Oggi, la banalizzazione della narrazione pare aver sottovalutato se non dimenticato questo, cruciale, aspetto. Non è un problema di sola comunicazione. O meglio, la comunicazione è l’epifenomeno di un modo di pensare e agire. Dietro alla banalizzazione degli oppositori (non tanto quelli politici ma quelli che siedono nei gangli del potere) in gufi, rosiconi e professoroni, non risiede soltanto un impeto da “rivoluzione culturale” maoista, ma una profonda sottovalutazione del loro potere o, molto più probabilmente, una terribile sopravvalutazione del proprio potere come classe politica.
Della stagione del primo renzismo, in attesa di capire se ve ne sarà un secondo, sul piano delle realizzazioni materiali del proprio riformismo, così tanto sbandierato, molto rimarrà come un incompiuto. Non tanto perché l’esito referendario ha interrotto l’esperienza del governo Renzi, ma perché molte delle riforme hanno cozzato con la verifica tecnico amministrativa di altri organi dello Stato.
La riforma della pubblica amministrazione, bocciata in parti consistenti dalla Consulta, la legge elettorale che ha subito medesima sorte, buon ultimo il TAR che ha censurato la Riforma dei Beni Culturali del ministro Franceschini. A questo possiamo aggiungere gli errori, marchiani e palesi, del nuovo Codice degli Appalti, che hanno generato numerosi rilievi del Consiglio di Stato.
Rilievi che hanno a loro volta dato avvio alla figuraccia della riforma (a parere di chi scrive sacrosanta) dei poteri abnormi dell’ANAC approvata dal Consiglio dei Ministri all’insaputa del consiglio stesso.
Errori che sono stati quasi sempre imputati alla irruenza e alla fretta riformatrice della passata stagione del governo o, dagli stessi protagonisti, a nemici esterni, spesso identificati come parrucconi dell’ancient regime.
Probabilmente c’è del vero nella seconda affermazione e a leggere, uno dietro all’altro, i tre cognomi della giudice che ha formulato la sentenza del TAR sulla riforma Franceschini, questa tesi si può pure rafforzare, se ci è concessa un po’ di ironia.
Tuttavia proprio se questa tesi fosse vera, ancora di più emergerebbe il limite politico di quella stagione di governo. Sottovalutare il proprio avversario è infatti molto spesso il primo passo verso una sconfitta certa. Anche la risposta “la prossima volta cambieremo prima il TAR del resto” ha più un valore propagandistico che reale.
Perché il punto anche se si decide di cambiare il TAR (anzi soprattutto se si decide di cambiare il TAR) è cambiarlo bene, in modo formalmente e sostanzialmente perfetto, a meno che non si intenda cambiarlo attraverso un sovvertimento violento dell’ordine costituito.
Ecco dunque che all’approssimarsi dell’ennesima campagna elettorale in cui il segretario del PD, continuerà con la litania delle prossime riforme che metterà in campo qualora dovesse tornare a Palazzo Chigi, la differenza potrà farla soltanto se si soffermerà sul fatto che, al netto degli argomenti scelti, le prossime riforme si impegnerà a farle bene.
Certo questo impone di scegliere i capaci al posto di fedeli, cosa che finora è parsa più difficile dello scrivere le riforme correttamente.
Articolo apparso su CulturaCommestibile n. 220 del 3 giugno 2017