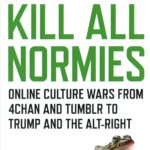Per anni dietro le mie spalle, nel mio ufficio di allora, ho avuto un manifesto (se non ricordo male era dell’ARCI) con il motto medievale tedesco: “l’aria delle città rende liberi”. Ci ripensavo in questi mesi di pandemia quando l’aria delle città – più correttamente degli sprawl – appare quella meno salubre e più feconda per la trasmissione del virus. Ragionamenti che anche sociologi, urbanisti, amministratori, stanno provando a fare, approfittando del virus come occasione di ripensamento e ridisegno degli spazi del nostro abitare.
Non tanto come metodo di lotta al virus, si spera che i tempi di cura del COVID non siano quelli medi del ridisegno delle nostre città ma molto, molto, più rapidi, piuttosto un ripensamento che va in direzione di una sostenibilità ambientale e come precauzione per le prossime crisi, non necessariamente pandemiche, che come ci insegna David Quammen in Spillover ci troveremo, anche a causa del nostro sviluppo ad affrontare. Mentre qui da noi si oscilla tra archistar che blaterano di un ritorno ai piccoli borghi, amministratori che aborrono lo smart working per non far chiudere il baretto sotto la Regione e un generale senso di “add’ha passà a nuttata”, nel resto del mondo qualcosa si muove in direzioni diverse e interessanti. Rispondendo ad una intervista del Sole 24 ore del settembre scorso Richard Florida, l’urbanista guru della società della conoscenza che tanto ha plasmato gli anni dell’ottimismo obamiano, ha riletto la sua concezione di egemonia della classe creativa alla luce del COVID-19. Fine delle metropoli, ritorno alla media dimensione urbana. Va considerato che Florida parla del contesto americano e quelle che lui considera grandi città non sono certo le dimensioni delle nostre cittadine italiane. Dunque paradossalmente i nostri centri urbani potrebbero partire avvantaggiati rispetto a questa nuova fase. Anche perché il secondo elemento che Florida ritiene determinante nella città post pandemica è la piazza. Istituzione italiana per eccellenza, che non viene declinata al virtuale ma proprio come spazio di aggregazione e, perché no, di lavoro, legata allo smart working.
Inutile dire che la riflessione di Florida, così come la sua teoria più famosa, affronta il livello medio alto della società, quello che può telelavorare, quello che è sopravvissuto alla rivoluzione dell’ICT e che sopravviverà alla rivoluzione della robotica. Noi invece qualche problema su come sopravviveranno, anche in termini urbanistici, i milioni di lavoratori poco o per nulla qualificati nel processo di espulsione della loro forza lavoro ad opera dei robot vorremmo provare a porlo. Magari con soluzioni non troppo diverse, possibilmente, di quelle immaginate per la parte ricca (di soldi e di conoscenza) della popolazione.
Anche in Canada, precisamente in Québec, il tema è stato affrontato. Le smart city, il lavoro che cambia, le nuove generazioni iperconnesse erano alcuni dei temi della MTL Connect che si è svolta, per larga parte online, la scorsa settimana. In questo caso siamo già a i primi ripensamenti ad un ridisegno delle smart cities a partire dal fallimento di Toronto Google city.
Anche da questa parte dell’oceano però non si sta con le mani in mano. La città di Parigi ha iniziato il percorso di ridisegno del proprio strumento di programmazione urbanistica, ponendosi (prima del COVID) l’obbiettivo di un piano a bilancio ambientale positivo. Per cui dal consumo di suolo si passa alla restituzione di verde e aree umide in misura maggiore a quelle in cui si continuerà a colare cemento.
All’interno di questo processo, che prevede anche interessanti esercizi di democrazia partecipativa, Le Monde ha dedicato lo scorso 16 ottobre due pagine agli interventi di due urbanisti ed una sociologa sul tema del nuovo PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ebbene tutti e tre gli interventi andavano nella direzione di Florida, del superamento della scala urbana della rottura della continuità del costruito. Più radicale, anche nella critica, l’urbanista Albert Levy che poneva come efficace non il limite della città (stiamo comunque parlando di Parigi) e nemmeno quello dell’aria ad essa confinante ma quello dell’intera regione parigina. Parlando in termini di difesa dai cambiamenti climatici, in particolare del surriscaldamento urbano, anche in termini sanitari. Scrive Levy: “lottare contro l’isola di calore urbano ed i suoi effetti sanitari deleteri deve divenire l’obiettivo prioritario dell’urbanistica bioclimatica, rinforzando il posto della natura nella città: ripiantare verde e alberi lungo le strade e nelle piazze, diversificare la vegetazione, rendere verdi facciate e tetti, sviluppare l’agricoltura urbana, gli orti comuni, i parchi, le trame verdi e blu, bloccare l’artificializzazione del suolo, demineralizzare il suolo, favorire l’infiltrazione naturale della pioggia, incoraggiare la fitoterapia, manutenere i corsi d’acqua”. Sono questi gli assi dello sviluppo urbanistico di Parigi, che però se vuole avere un senso deve avvenire a livello di scala regionale, avendo poco senso un salotto verde attorniato da banlieue cementificate, aeroporti intercontinentali e fabbriche inquinanti. Rompere il tessuto urbano, ridare soluzioni di continuità ad un tessuto che si è espanso senza fine e senza senso.
Queste le tesi anche di Agnés Sinaï e di Antoine Grumbach che vanno entrambi nella direzione della fine dell’urbanistica della congestione, la prima, e di una forse utopica riscoperta del territorio e della sua gestione armoniosa per il secondo.
Comunque il punto di fondo è la fine della megalopoli come modello di sviluppo, un ritorno a rotture tra città e campagna con quest’ultima fortemente collegata da infrastrutture tecnologiche e materiali ad impatto però ridotto.
Uno scenario che potrebbe vedere l’Italia e in particolare quel territorio centrale che va dagli Appennini alla Capitale come un unico scenario di sviluppo di queste nuove competenze, di un modello bioclimatico a cui si aggiungerebbero le bellezze architettoniche, artistiche, storiche e paesaggistiche ed un modello di sviluppo economico diffuso, ridisegnando e sostenendo in infrastrutturazione, ricerca e sviluppo il tessuto di medie e piccole imprese.
Potremmo essere capofila di un modello di sviluppo che per le parti più avanzate del pianeta vorrebbe dire cambio traumatico di traiettoria, mentre per noi, prosecuzione di un cammino millenario. Potrebbe, a patto di non limitare l’ottica ai dehors dei bar e ristoranti oramai vuoti, al museo da tornare a riempire e alla ZTL da perforare.
Articolo apparso su Cultura Commestibile.com n. 374 del 24 ottobre 2020