
Pubblichiamo qui l’intervento tenuto il 21 settembre scorso all’incontro Firenze per il domani presso la Sala Spadolini del ristorante La Loggia di Firenze.
Nel nostro Paese il tema del lavoro, nonostante un po’ di decentramento tentato con la riforma del Titolo V della Costituzione, è per storia e prassi tema prettamente nazionale; e tuttavia è chiaro che l’organizzazione del lavoro influisce, tanto per dirne una, sull’organizzazione degli spazi della città mentre politiche di welfare determinano attrattività per capitali e lavoratori o al contrario respingono imprese e forza lavoro.
Come quindi ha influito e influisce il tema del lavoro sulla realtà di una città come Firenze? Si proverà qui a dare tre ambiti di riflessione sui quali poter impostare un discorso pubblico e un’ipotesi di città, partendo da tre linee di frattura, due già verificate e la terza in via di determinazione. Tre cesure che rappresentano altrettante distanze tra la sinistra riformista e una grande parte di quello che era il suo popolo, il suo elettorato.
La prima cesura è quella relativa al rapporto che in questi anni il centrosinistra, a Firenze come a livello nazionale ha avuto nel confronto del lavoro.
In questi anni, naturalmente a mio parere, l’aver concentrato larga parte della comunicazione sulle “eccellenze” ha finito per far sentire estranea larga parte dei lavoratori del Paese (che molto spesso non hanno le condizioni per essere eccellenze né possono lavorare per una di queste) e questi hanno finito per non sentirsi parte del discorso pubblico del centrosinistra.
Brutalmente, pur capendone le ragioni (la ricerca dell’ottimismo e dell’esempio), si è parlato ad una platea amplissima mostrandogli esempi irraggiungibili, per le condizioni economiche e sociali del Paese o banalmente per una mera questione di tempo.
Porre come manifesto della imprenditoria della fase che si stava vivendo, per esempio, un imprenditore quale Farinetti, con la sua retorica del buono e bello nella produzione alimentare che messaggio ha dato a quell’imprenditore pugliese a cui una marca della grande distribuzione ha bloccato l’acquisto dell’intera produzione perché un grappolo, un solo singolo grappolo, di un intero pancale non era visivamente conforme?
E questo tipo di comunicazione è avvenuta anche a Firenze, anzi talvolta la nostra città ne è stata anticipatrice, dispiace dirlo. E questo ha vanificato anche le azioni politiche fatte o le politiche per il lavoro e i lavoratori che sono state intraprese in questo territorio ottenendo anche risultati. Purtroppo però il discorso pubblico, certo per colpa anche dell’informazione sia chiaro, è ormai così compromesso che il 12 settembre scorso i giornali locali titolavano sulla bistecca patrimonio dell’umanità e non sulla rinascita della Seves.
Capisco che parlare di operai e facchini non sia eccitante come parlare con vinificatori, artisti o capitani di industria e che se la risposta è portarli a cena si va poco lontano, però questo tema, a mio avviso, è urgente e necessario. Per questi lavoratori la crisi non è mai finita e anzi, anche qui da noi, in alcuni casi rischia di iniziare ora.
La seconda cesura è una cesura fisica, materiale ed è più propriamente legata alla città e alle sue politiche. È questa una frattura che si determina visivamente nel territorio della città o meglio dell’area fiorentina.
Una mano anonima, ma non stolta, ha scritto a ragione, sui muri della facoltà di architettura qui a Firenze, la frase: “l’urbanistica è l’organizzazione capitalista dello spazio”; ecco partendo da questo assunto occorre ridefinire e determinare le scelte dello sviluppo della città, in questo caso della città metropolitana in base anche alla tipologia di sviluppo economico che si immagina per il territorio. A questo si lega lo sviluppo della rete infrastrutturale e dei servizi.
È avvenuta, ed è ancora in corso invece, una frattura fra una città che produce e una che consuma la propria storia e ricchezza. In questo la scelta di non far attraversare il centro storico dalla tramvia, aldilà dei giudizi che si dà all’operazione, ha determinato una cesura e una compartimentazione economica fra la città che si nutre sul turismo e la città (vasta) che produce ricchezza sugli altri settori.
È questa una cesura che può essere invertita solo con una riflessione sulla contaminazione dei due ambiti, con una nuova politica che riporti residenza, lavoro e non rendita nel centro storico e che definisca che la vocazione produttiva dell’area fiorentina è anche altro rispetto all’attrazione turistica, lo sfruttamento delle proprie bellezze e una vetrina per multinazionali ed eccellenze.
Messe in questo contesto, per esempio, scelte infrastrutturali quali l’aeroporto, l’alta velocità o lo sviluppo urbanistico dell’area fiorentina troverebbero materia di confronto un po’ più seria delle beghe di campanile e probabilmente anche una qualche soluzione.
Infine la terza frattura è quella potenzialmente più rischiosa, quella che può divenire un canyon. È ormai in atto nel mondo un processo di robotizzazione del lavoro che, seppur da noi con qualche ritardo, vedrà drasticamente cambiare il rapporto con il lavoro. La robotizzazione del settore dei servizi, dalla logistica all’assistenza, comporterà una espulsione di forza lavoro con numeri previsti enormi. Stiamo parlando di forza lavoro non qualificata e, a causa delle politiche pensionistiche di questi anni, in buona parte di età avanzata. È un processo globale, che necessita probabilmente di politiche sovranazionali, ma che, è facile profetizzare, avrà ricadute sulle nostre città, col rischio di creare ulteriori ghetti, di alimentare paure e insicurezze. Servirebbe arrivare pronti all’appuntamento, pensando già da ora politiche, spazi e azioni per l’inclusione, la mixitè e il reimpiego di questi uomini.
Perché l’alternativa a una politica che include e non esclude è già in elaborazione. Salvo che da noi, per l’approssimazione dell’attuale classe di governo, la discussione sul reddito di cittadinanza è proprio funzionale a gestire questa (temo lunga) fase di transizione di masse di lavoratori non più impiegabili, attraverso un sussidio assistenziale pagato con una (minima) parte dei guadagni che arriveranno con l’efficientamento dovuto alle macchine.
In un bellissimo libro sulle intelligenze artificiali scritto dal direttore del laboratorio su queste ultime dell’università di Oxford, questo passaggio epocale è descritto paragonandolo a quanto accadde ai cavalli dopo la II rivoluzione industriale. Lascio a voi giudicare se questo passaggio sia o meno auspicabile.
Racconta il professor Bostrom che con la seconda rivoluzione industriale la popolazione di cavalli dell’occidente fu decimata. Non servivano più né per il lavoro dei campi, né per il trasporto delle merci, sostituiti da trattori, camion e treni. Però, ci dice speranzoso Bostrom, dopo qualche decina di anni la popolazione equina è ricominciata a crescere e di molto. Il cavallo da animale da lavoro è diventato animale da sport, compagnia, persino cura e le razze selezionate sono oggi più forti e prestanti.
Questo è uno degli scenari, perché non divenga l’unico scenario occorre immaginare fin da ora come passeremo dai cavalli da tiro ai cavalli da salto, immaginando che nessuno di noi pensi a un presente fatto di carne in scatola.
Articolo apparso sul numero 279 del 6 ottobre 2018 di Cultura Commestibile









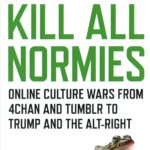


 Cambiare paradigma su millenni di evoluzione, abbassare la nostra superbia e dimenticare tutte le lezioni che ci hanno propinato dalle elementari in poi, “dell’uomo al vertice della catena evolutiva”. E’ questo l’insegnamento maggiore che ci danno Fritjof Capra e Stefano Mancuso nella loro conferenza organizzata nell’ambito del master dell’università di Firenze dal titolo Futuro Vegetale che si è tenuta il 5 maggio scorso al Teatro Niccolini di Firenze.
Cambiare paradigma su millenni di evoluzione, abbassare la nostra superbia e dimenticare tutte le lezioni che ci hanno propinato dalle elementari in poi, “dell’uomo al vertice della catena evolutiva”. E’ questo l’insegnamento maggiore che ci danno Fritjof Capra e Stefano Mancuso nella loro conferenza organizzata nell’ambito del master dell’università di Firenze dal titolo Futuro Vegetale che si è tenuta il 5 maggio scorso al Teatro Niccolini di Firenze. Ma come un altro spettacolo di teatro sul teatro? Un altro regista dispotico che dall’ombra determina i destini degli attori? Ma sì se lo spettacolo è Audizioni di e con Alessandro Riccio In scena fino a domani 29 aprile al teatro di Rifredi di Firenze. Spettacolo diretto, crudo ma al tempo stesso divertente e con una bravura attoriale di Riccio e Gaia Nanni (coppia ormai affiatatissima sul palcoscenico) che dovendosi “combattere” per un unico ruolo da protagonista ci fanno dimenticare, come a loro comanda il regista/maestro nell’ombra, che siano un uomo e una donna a contendersi lo stesso ruolo. Un testo asciutto quello di Riccio che mette a disposizione del suo personaggio la sua fisicità, talvolta debordante, mettendosi a nudo, rispetto alle sue interpretazioni più celebri, restituendoci così un attore e il suo volto più autenticamente fragile. Fragilità che sembra il tratto dell’attrice interpretata da Gaia Nanni, che invece con maestria e talento cela e ci fa scoprire un personaggio multiforme fino al finale sorprendente che ti spiazza e ti fa esclamare: “ma dai! Che bravi”.
Ma come un altro spettacolo di teatro sul teatro? Un altro regista dispotico che dall’ombra determina i destini degli attori? Ma sì se lo spettacolo è Audizioni di e con Alessandro Riccio In scena fino a domani 29 aprile al teatro di Rifredi di Firenze. Spettacolo diretto, crudo ma al tempo stesso divertente e con una bravura attoriale di Riccio e Gaia Nanni (coppia ormai affiatatissima sul palcoscenico) che dovendosi “combattere” per un unico ruolo da protagonista ci fanno dimenticare, come a loro comanda il regista/maestro nell’ombra, che siano un uomo e una donna a contendersi lo stesso ruolo. Un testo asciutto quello di Riccio che mette a disposizione del suo personaggio la sua fisicità, talvolta debordante, mettendosi a nudo, rispetto alle sue interpretazioni più celebri, restituendoci così un attore e il suo volto più autenticamente fragile. Fragilità che sembra il tratto dell’attrice interpretata da Gaia Nanni, che invece con maestria e talento cela e ci fa scoprire un personaggio multiforme fino al finale sorprendente che ti spiazza e ti fa esclamare: “ma dai! Che bravi”.
