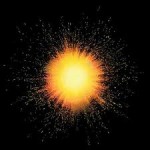Di Riccardo Conti sono stato orgogliosamente “nipotino indisciplinato” e non è dunque facile scriverne a meno di due anni della sua prematura scomparsa. Tuttavia la pubblicazione, a cura della sezione Toscana dell’INU, del numero monografico di Urbanistica e Dossier a lui dedicato merita di cacciare indietro il magone e provare a ragionare su Riccardo Conti nel suo fare urbanistica, che è poi anche il titolo della pubblicazione.
Il volume raccoglie scritti di chi con Riccardo condivise una stagione amministrativa e riformista, come la chiamava lui, irripetibile. Intanto per il metodo, un incontro di sapienti e di politici, così inimmaginabile nella stagione dei “professoroni”, dell’inesperienza come valore, dell’università della vita. Erano anni in cui i Direttori generali dei vari assessorati della Regione Toscana non avrebbero sfigurato nelle cattedre dei migliori atenei del Paese e in cui, noi capi di gabinetto, temevamo il maglio del CTP del giovedì molto più della scure della giunta politica del lunedì. Nel volume c’è appunto il racconto di Mauro Grassi che ci fu rubato dalla Cultura proprio per approdare all’assessorato di Riccardo e con lui coordinare una squadra formidabile che avrebbe disegnato una Toscana capace non solo di preservarsi ma di svilupparsi.
Riccardo, cresciuto con la cultura onnivora di quelli per cui studiare era la prima forma di riscatto, declinava lo sviluppo territoriale come sviluppo economico, si ostinava a non vedere la terra che era stata della Galileo, del Pignone e della Piaggio a un’eterna Disneyland che consumava il suo passato o nella trasformazione in un Chiantishire fatto di vincoli ad ossimorum. La sua idea di progresso passava dalla città lineare da Firenze al mare, nell’alta capacità che univa Livorno a Rotterdam. C’era in lui un forse ingenuo sviluppismo, un mito di progresso che certo prevaleva su un ambientalismo da salotto, sull’immobilismo progressista che vedeva in una fabbrica di caravan un nemico di classe.
La Toscana di Riccardo era vigne a giropoggio, come aveva letto in Emilio Sereni, ma anche l’Arno Valley il cui poster era appeso nella sua stanza di vicepresidente della Provincia. Lo sguardo dritto e fiero nel futuro non lo abbandonava mai, ma era un futuro fatto sì di rispetto ambientale ma non certo di immobilismo luddista. A Riccardo piaceva il progresso e sognava riforme per sviluppare. Era felice la crescita per lui, mai il suo contrario.
Certo non fu semplice lavorare con Riccardo, rapportarsi con lui come ricorda il nostro Gianni Biagi anch’egli autore di uno scritto della monografia sui rapporti, talvolta burrascosi tra i piani regionali e quello comunale a cui forse un eccesso di critica da parte della Regione contribuì a far allungare il dibattito fino a che il vento che soffiava da Rignano ne decise la fine, più consona alla stagione nuova che rappresentava.
Ma il metodo di Riccardo era un metodo curioso, pedagogico. Intergenerazionale. Quanti giovani devono a Riccardo occasioni di confronto e crescita, opportunità di incarichi, tutti meritati, quanto meno per la qualità di quelli che ci sono succeduti. Ed ecco che è così bello leggere le pagine di Chiara Agnoletti, anche lei cresciuta alla scuola dei nipotini di Riccardo, mai geloso e sempre pronto a sorreggere anche quelli più riottosi di noi.
Quella stagione siamo certi non tornerà più e magari è meglio così, ma riappropriarsi di quel metodo, di quella curiosità, della mazzetta dei giornali esagerata sempre sotto il braccio di Riccardo, sarebbe oggi più che mai una necessità dell’agire politico.
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza” campeggiava in effige all’Ordine Nuovo gramsciano e Riccardo ne seguì fino all’ultimo il comando. Ricordarlo oggi continuando a studiare è il modo migliore per occuparsi del territorio, anche ferito, che ci circonda.
Articolo uscisto su Cultura Commestibile n. 298 del 2 marzo 2019.