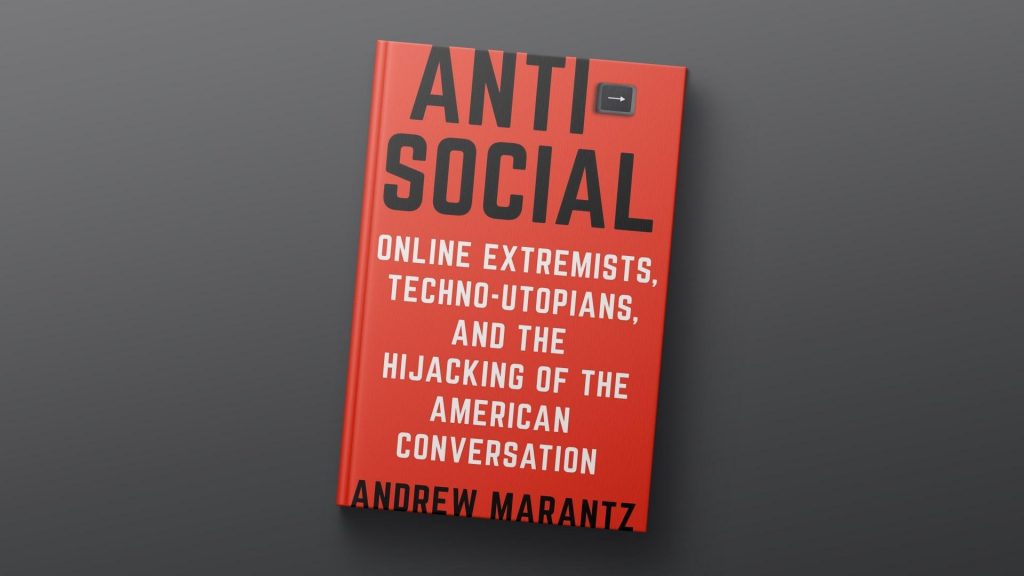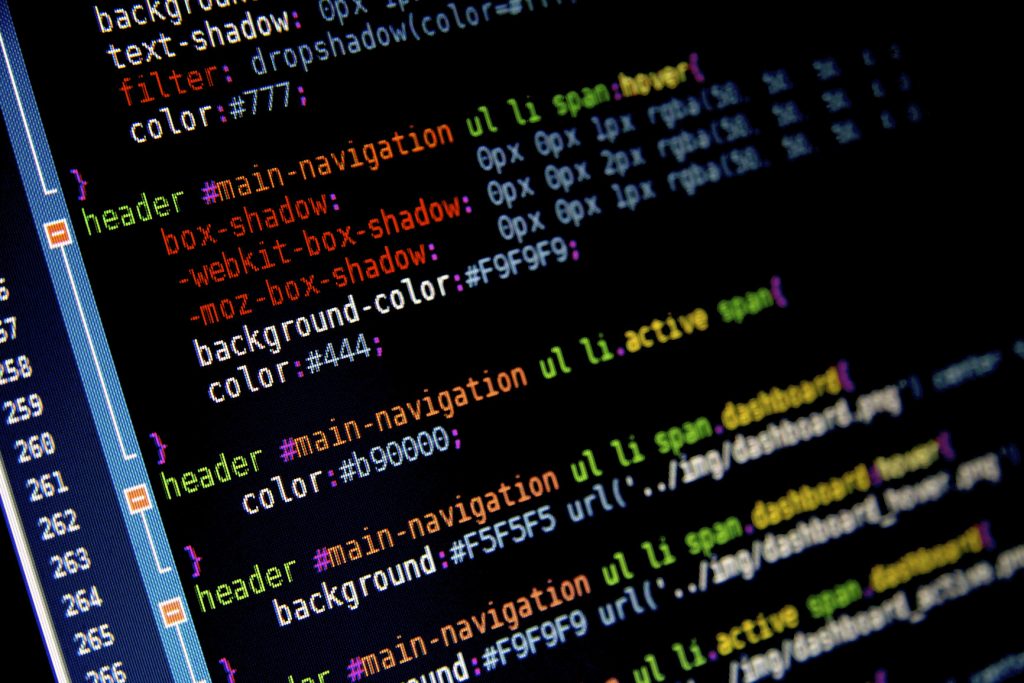Se nel proprio nome (o cognome in questo caso) risiede una parte del proprio destino, Ottavio Fatica intraprendendo la traduzione del Signore degli Anelli ha molto probabilmente compiuto il suo.
Già perché le vicende editoriali di questi tre volumi, in Italia, non sono mai state facili e anche questa volta si confermano tali. Credo c’entri anche un’appropriazione politica del testo tolkeniano da parte dell’estrema destra e del neofascismo dagli anni ’70 del tutto incomprensibile all’estero e a chi ha davvero letto (e mi si permetta capito) la saga dei Baggins.
Ma le critiche al lavoro di Fatica non sono arrivate solo dai nostalgici, c’è infatti una moltitudine di ex adolescenti (come chi scrive) che sono cresciuti forgiati da quel libro che circolava con la sua copertina agreste dai contorni beige e apriva mondi che poi spesso portavano a pomeriggi di giochi di ruolo.
Ma facciamo un po’ di ordine e proviamo a ricapitolare in estrema sintesi le vicende del libro nel nostro paese. La prima traduzione del volume è quella, in realtà mai arrivata alle stampe, che la piccola casa editrice l’Astrolabio commissiona ad una allora giovanissima Vittoria Alliata di Villafranca. La Alliata che non era (e non sarà) una traduttrice fa, va detto, un lavoro enorme e per i suoi mezzi egregio, tuttavia fu poi affiancata da Quirino Principe che ne corregge molta parte per l’edizione Rusconi che uscì nel 1970.
Quella traduzione è quella sulla quale generazioni di lettori sono cresciuti e si sono affezionati. Tuttavia nel 2003 Bompiani proporrà, alla ripubblicazione dei volumi sull’onda del successo dei film tratti dagli stessi, quella traduzione, però corretta su indicazione della Società Tolkeniana Italiana.
Sì perché nel frattempo il Signore degli Anelli e più in generale l’opera di Tolkien stava uscendo dalle fogne del neofascismo e dall’underground di cosplay e nerd ed entrava di diritto nei canoni letterari e nelle aule universitarie. Da qui, all’approssimarsi della scadenza dei diritti della traduzione dell’Alliata, la pressione sull’editore per una nuova traduzione.
Non senza strascichi legali, cause e velenosi articoli usciti sui giornali della destra italiana si arriva dunque all’opera di Ottavio Fatica, traduttore di grande esperienza con un gran lavoro su prosa e poesia inglese. Ma in cosa si caratterizza questo lavoro? La più evidente differenza (e quella su cui si sono concentrate le maggiori polemiche) è la traduzione diversa di molti dei nomi iconici della saga. I Raminghi che diventano Forestali, il Puledro impennato Cavallino Inalberato, Gran Burrone Valforra e molti altri. Un lavoro che il traduttore ha sempre giustificato per una maggiore aderenza alle sfaccettature e alle etimologie dell’autore. Non va infatti dimenticato che Tolkien di mestiere faceva il filologo a Oxford e tutte le sue opere sono caratterizzate per scelte linguistiche precise e mai casuali. Anche la poesia degli anelli che più o meno tutti i fan conoscevano a memoria viene riportata ad una maggiore coerenza con l’originale ma non è facile mandarla a memoria nella nuova versione.
E tuttavia a Fatica e all’editore è mancato il coraggio di utilizzare tale metro per tutti i nomi della saga (da un certo punto di vista fortunatamente) e dunque Baggins non è reso con Sacconi. Una scelta certo comprensibile che però avrebbe potuto essere adoperata per altri personaggi ed evitare che ogni volta che ci si riferisca ad Aragon come forestale non venga in mente uno in uniforme grigia intento a controllare che scoppi un incendio nel bosco.
Ma le due, a mio avviso, più importanti novità della traduzione di Fatica sono l’uso di registri diversi da parte dei personaggi e una fluidità e musicalità del testo. Il primo punto fa sì, per esempio, che le modeste origini di alcuni personaggi, Sam su tutti, si riflettano nel loro parlato. Questo fa sì che l’opera acquisti le sfaccettature che l’autore volle dargli: non una semplice saga epica fatta di eroi ma un’allegoria di una quotidianità che si trasforma in epica. Gli Hobbit non sono eroi scelti dagli dei, ma (mezzi)uomini travolti dal fato che compiono imprese eroiche. Una stratificazione di classe che era ben presente in Tolkien e che lo allontana dalla mistica del superuomo (che aveva trovato spazio quasi solo qui in Italia infatti).
Articolo uscito su Cultura Commestibile, n. 460 del 17 settembre 2022.