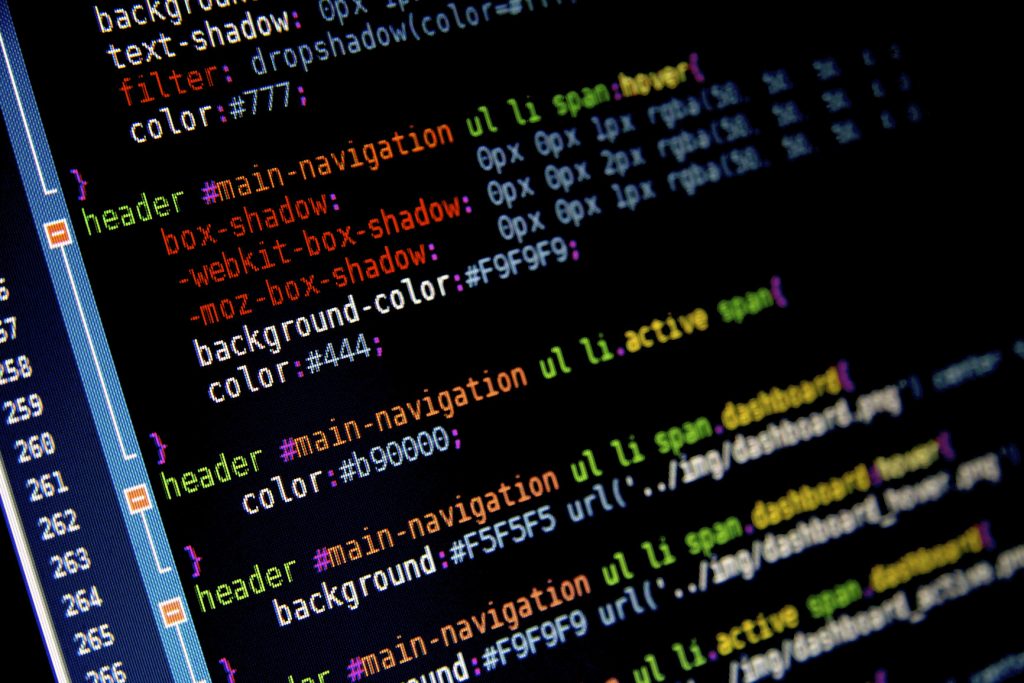
La nostra collaboratrice Maria Mariotti si è, giustamente, risentita per il fatto che Facebook ha cancellato, dal suo profilo, il suo articolo apparso sulla nostra rivista sabato scorso, che aveva come immagine a corredo una foto con tre donne etiopiche a seno scoperto.
Si trattava di una cartolina che i nostri coloni mandavano in patria per magnificare cosa trovavano nell’impero. Per ironia della sorte all’immagine di Maria è toccata la stessa sorte che sarebbe toccata alla cartolina fosse stata intercettata dalla censura del Ministero per l’Africa italiana che non vedeva di buon occhio tali pratiche perché toglievano purezza alla razza, come ricorda Emanuele Ertola in un bel libro Italiani d’Africa.
Ma il tema sollevato è molto più ampio e annoso. Le piattaforme informatiche, non solo quelle di social network, per anni si sono sempre considerate non responsabili dei contenuti pubblicati sulle loro pagine. Non degli editori quindi da dei meri fornitori di uno strumento. Essendo tutte nate negli Stati Uniti esse risentono di una certa inclinazione a far prevalere il diritto di espressione rispetto a quello di tutela dei dati e dell’onorabilità dei fruitori. A differenza di quello che avviene qui in Europa dove si ha una maggiore attenzione al secondo aspetto.
Tuttavia, fin dall’inizio della loro espansione le piattaforme social si sono poste il tema della “moderazione” dei contenuti che venivano pubblicati sul loro strumento. La prima impiegata assunta da Facebook a tale scopo fu assunta tre anni dopo la nascita del social network nel 2004. A differenza, infatti, di quello che normalmente si pensa la questione non è gestita soltanto dagli algoritmi e oggi Facebook ha diversi uffici sparsi per il mondo che controllano i contenuti postati e le segnalazioni con competenza, ognuno, per una determinata area geografica.
Il reporter del Newyorker, Andrew Marantz, ha dedicato al tema un bel volume, Antisocial, e numerosi articoli sulla rivista, uno dei quali proprio sul rapporto tra Facebook e la politica di gestione dei contenuti, apparso sul numero del 12 ottobre 2020 della rivista.
Quello che emerge dalle inchieste di Marantz è che Facebook, ma il discorso può valere anche per gli altri social, ha politiche rispetto a cosa viene pubblicato sulle proprie pagine diverse a seconda del contesto, della convenienza “politica” dell’azienda ma anche del “vento che tira”.
Unica costante, di cui ha fatto le spese la nostra collaboratrice, il nudo e i contenuti pornografici che paiono essere sempre e comunque boccati applicando l’adagio delle truppe sovietiche a Stalingrado, prima spara poi fai le domande.
Così non è stato invece per organizzazioni e gruppi neonazisti qui in Europa che hanno goduto a lungo di un diritto di tribuna piuttosto esteso e incontrollato e che hanno visto bloccare le loro pagine, immaginiamo del tutto casualmente, mentre l’Unione Europea affrontava il tema della privacy e della tassazione degli utili delle piattaforme.
Casi ancora più marcati riguardano le “concessioni” ai regimi mediorientali o a quello cinese che tutte le piattaforme hanno accordato per non perdere l’accesso al mercato cinese.
Anche negli Usa le cose non sono andate meglio. C’è stato il caso di Cambridge Analitica, il sostanziale “mani libere” accordato a Trump e ai suoi sostenitori per tutta la sua prima campagna presidenziale e per larga parte del suo mandato. Poi col cambiare del vento, qualcosa lì si è mosso. Ricorderete l’audizione di Marc Zukerberg al congresso americano, incalzato dalle domande della Ocasio Cortez e poi la scelta di Twitter (che ha costretto le altre piattaforme ad adeguarsi) prima a segnalare, poi a oscurare e infine a bloccare i tweet del Presidente in carica Donald Trump.
È oggi del tutto evidente che il tema della neutralità delle piattaforme non ha più senso. Da qui discende una necessità di chi e come si regolano i contenuti che hanno oramai in modo inconfutabile dimostrato la loro pericolosità sia a livello individuale che sociale.
L’idea che trattandosi di aziende private queste abbiano il diritto di autoregolarsi a piacimento, non è un concetto in contrasto con i dogmi del socialismo reale ma con i principi della democrazia liberale. Da sempre gli organi di informazione sono soggetti regolati e soggetti al controllo pubblico. Leggi, organismo, comitati di garanzia, da sempre e in ogni ordinamento democratico regolano la vita di stampa, radio e televisione.
Nel caso della rete il problema si complica di molto per due fattori su tutti. La quantità di utenti e contenuti e per la dimensione sovranazionale delle piattaforme.
Nel primo caso una proposta potrebbe essere quella di far sviluppare, gestire e implementare gli algoritmi di controllo non alle stesse piattaforme ma a soggetti regolatori pubblici o comunque indipendenti; mentre per il secondo punto occorrerebbe conferire il mandato del controllo ad agenzie sovranazionali in ambito almeno europeo, per quanto ci riguarda, e magari in ambito di nazioni unite per l’intero globo.
La trasformazione che questi strumenti hanno impresso alle nostre vite e soprattutto quella che hanno imposto alle nuove generazioni ci obbligano ad affrontare il tema e a dargli una risposta politica di dimensioni e confini nuovi ed inediti.
Articolo uscito su Cultura Commestibile n. 386 del 30 gennaio 2021







